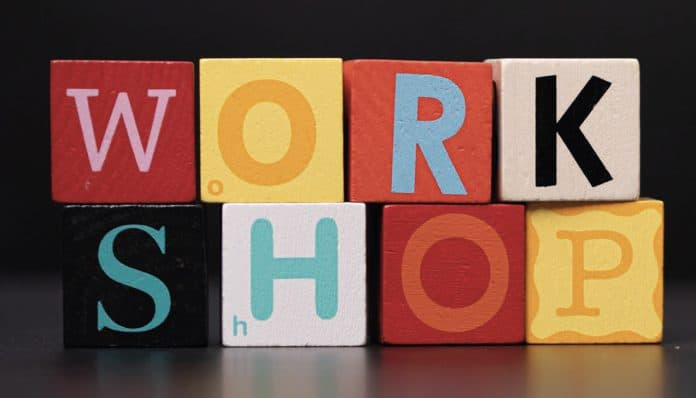di Marina Fabiano |
C’era una volta il workshop: che si chiamava anche seminario, meeting, convegno, team building. Di cui eravamo tutti assuefatti, anche un po’ stufi, non ne coglievamo più il valore. Minimo erano tre giornate piene, più il viaggio, talvolta lontano, quasi una vacanza premio, visto che tra una sessione e l’altra gli sponsor infilavano attività ludiche o culturali.
I contenuti erano comunque parzialmente interessanti, tra la formazione e il racconto pubblicitario, ma l’attenzione e il coinvolgimento erano contesi dalle impellenze del business: telefonate inderogabili, e-mail a cui dare risposte immediate, ordini da concludere. Se non sei un boomer, o almeno un tardo millennial, non puoi capire. Come non puoi capire il tenace attaccamento al lavoro, al ruolo, all’azienda che esisteva allora. Non sapevamo ancora dei mille cambiamenti organizzativi e relazionali che ci avrebbero travolto negli ultimi anni, a causa di una pandemia, innanzitutto, e della conseguente accelerazione tecnologico- digitale.
Workshop e inclusione digitale forzata
Durante il periodo pandemico ci siamo assuefatti all’inclusione digitale. Nel senso che – dopo esserci frettolosamente dotati del minimo indispensabile per essere sufficientemente produttivi da casa – ci siamo tuffati in ore e ore di incontri via web, facendo finta di capire e partecipare nonostante le mille interruzioni di linea e i disturbi familiari.
Le scuse formative, le riunioni inutili “ma in qualche modo dobbiamo continuare a relazionarci con capi/colleghi/collaboratori”, addirittura i festeggiamenti online per qualche traguardo centrato. Nel mix via web, a un certo punto sono entrati di prepotenza anche i workshop. Perché non si poteva più rimandare, perché erano visti come occasione di coinvolgimento – spesso obbligatorio – perché se non ci si poteva ancora incontrare fisicamente almeno ci si poteva vedere in faccia, con o senza filtri.
Forse è ora arrivato il momento di ridare spazio e dignità ai momenti di incontro fisico tra persone che hanno qualcosa in comune, soprattutto nella vita professionale: hanno dei saperi da condividere e lo vogliono fare. Nascono, e stanno cercando le proprie nuove dimensioni, delle rinnovate forme di generosa condivisione, in cui chi sa racconta, chi sa meno trova spazi di accoglienza. In particolare, per i moltissimi liberi professionisti senza colleghi e capi a cui appoggiarsi, con cui scambiare dubbi, a cui rubare conoscenze. Questo può succedere meglio nelle aziende, ma se si continua a lavorare senza incontrarsi, come si fa a “rubare” conoscenze? Non si vive di sola formazione, magari online, e poi la formazione continua (bella, eh!, ma non può continuare all’infinito) ha costi elevati ed è spesso solo un primo livello di apprendimento, perché tutta quella teoria va poi messa in pratica. E la pratica va controllata e misurata.
Fioriscono convegni
Diciamo che in qualche ottima occasione – da scegliere con accuratezza, nei temi e nei partecipanti – va considerata la possibilità di ritornare a far parte di convegni, seminari, gruppi che sentiamo affini. Talvolta l’investimento sarà di denaro, oltre che di tempo, ma ne varrà la pena. Non aspettiamoci poi che tutti i contenuti, tutti gli speaker, tutti i partecipanti siano utili, ma sicuramente qualcosa di buono lo porteremo a casa.
Boomer e millennial hanno avuto – hanno tuttora – un rapporto di sudditanza con il proprio ruolo, con l’azienda, con il settore in cui lavorano. Generalizzo, lo so, eppure il fondo di verità è evidente e ce l’hanno insegnato in famiglia inculcandoci il senso del dovere. Prima viene il lavoro, gli obblighi sociali, il dovere. Poi vengono le aspirazioni, i sogni, il piacere. I più giovani, meno abbarbicati a questi valori, al ruolo, al mondo professionale in cui ci riconosciamo, ci stanno insegnando qualcosa, se vogliamo avere l’umiltà di considerare utili alcuni dei loro atteggiamenti. Ci stanno mostrando la via di mezzo, il rispetto per le proprie soddisfazioni, magari attraverso periodi di test (provo a vedere se questo lavoro fa per me, se mi soddisfa, se no cambio genere), la ricerca del giusto bilanciamento tra devo e voglio. Tra impegno professionale e vita personale, che spesso si bilancia diversamente a seconda delle fasi di vita: non ho impegni personali, lavoro 18 ore al giorno; metto su famiglia e allora lavoro meno.
Quindi comincio a ponderare come spendo il mio tempo professionale, tot dedicato a produrre, tot investito in – appunto – riunioni, workshop, seminari, apprendimenti vari. Terrei isolato, perché già parte di un livello più elevato di volontà di scambio e costruzione formativa, il caso dei gruppi di pratica. Quei mix di persone che hanno alcuni tratti professionali in comune e che si mettono a disposizione per trasmettere esperienze e ricavare conoscenze dalle esperienze altrui. Ovviamente le conosco bene, queste comunità, nel mondo del coaching, ma ne sto vedendo e incoraggiando il proliferare tra gruppi di professionisti del digitale, bistrattate partite iva che – spesso non trovando degne occupazioni come dipendenti – si spalleggiano e si sostengono a vicenda.
E anche comunità femminili, dove dirigenti-donna che hanno trovato i propri spazi di soddisfazione professionale agiscono da mentor verso giovani e brillanti professioniste alla ricerca di sentieri meno spinosi per crescere come manager d’azienda. Cito solo un paio di gruppi, più o meno noti: Girls Restart, Freelance Camp, Global Leadership Foundation, Aiesec. Sicuramente ne esistono molti altri, sicuramente sarebbe altrettanto opportuno che se ne diffondessero molti altri, ne abbiamo bisogno. Perché è il metodo più genuino per far girare esperienze e conoscenze senza scopo di lucro o di scambio favori.
REGOLE AUREE PER INVESTIRE, BENE, TEMPO E DENARO IN UN WORKSHOPA questo punto occorre decidere con oculatezza. A quali eventi partecipo? Cosa mi riprometto di ricavarne? Come trarre il massimo dagli incontri a cui decido di partecipare? Ecco poche, semplici, ma irrinunciabili regole.
Tutto scontato? Repetita iuvant, dicevano quelli istruiti. |